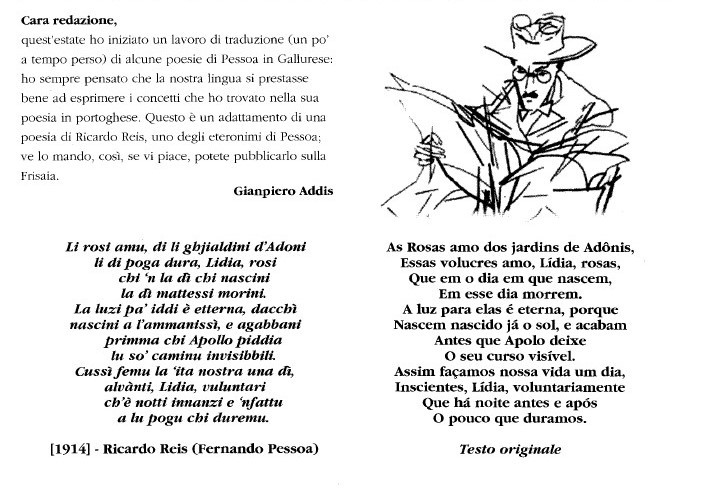I bombardamenti sono iniziati nella giornata di al-Hijriyah (il primo giorno del calendario islamico); io ero libero dal lavoro per via delle feste nazionali collegate, e mi stavo preparando ad un lungo fine settimana di quattro giorni. Da allora ho trascorso quei quattro giorni rinchiuso a casa mia, a Remal, Gaza, un quartiere benestante di Gaza City. Sono fortunato a non vivere nelle aree di confine, o nei campi densamente popolati e affiliati ad Hamas. Ciò non significa affatto che io mi senta al sicuro.
Dal momento in cui sono cominciati i bombardamenti ho maledetto il centro commerciale costruito di recente che svetta al di là di casa nostra. Non solo ha violato tutte le deboli leggi urbanistiche di Gaza, ma il proprietario era noto per essere un simpatizzante di Hamas: ogni giorno ho temuto che potesse essere uno dei bersagli dei bombardamenti di Israele. La lista degli obiettivi di Israele sarà ispezionata e discussa all’indomani di questa operazione; al momento pare che si tratti di un miscuglio di siti per il lancio di razzi, di militanti pre-identificati, di depositi di armi, e poi ci sono gli obiettivi “simbolici”, ognuno dei quali implica un diverso calcolo strategico per Israele; ma dal nostro punto di vista, la presa di mira simbolica di edifici governativi è sconcertante tanto quanto la decisione di rispondere a razzi fatti in casa con bombe sganciate dagli F-16. E ognuna di queste mette a rischio vittime civili, quel “danno collaterale” che esce con molta facilità da troppe lingue.
Nelle prime ore del mattino di domenica, Jawazat, un grande complesso di edifici di polizia distante solo pochi minuti dalla mia abitazione, e vicino alla mia pizzeria preferita, è stato distrutto. Ha fatto seguito una tregua ingannevole, che ha generato ore di silenzio e attesa durante le quali non abbiamo osato avventurarci fuori. Mi sono seduto a casa con la mia famiglia, facendo congetture sull’ipotesi di un accordo di cessate il fuoco: le nostre paure e speranze sono venute fuori quando abbiamo iniziato a pensare che i nostri leaders avrebbero potuto essere prossimi ad un accordo per mettere fine a questo orrore. Poi, in un attimo, quattro esplosioni da far fermare il cuore, una dopo l’altra, hanno scosso la nostra casa che un tempo era intoccabile. Mentre le esplosioni assordanti si placavano ho cercato di recuperare un po’ contegno; cerchi di essere stoico, quando i bambini incrociano il tuo sguardo. Però in quel momento mi sono reso conto che sono io il bambino; sono io quello che è un dilettante della guerra. I miei fratellastri, che hanno sette e dodici anni, sono dei veterani nella sopravvivenza durante le guerre, dato che nel 2008 sono sopravvissuti all’Operazione Piombo Fuso, al bombardamento e all’invasione di Israele, mentre io ero assente e al sicuro a Londra. Sabato scorso eravamo solo al terzo giorno dell’Operazione Pilastro di Difesa; i miei fratellini avevano già sperimentato tutto questo per ventotto giorni, trentuno se si considera anche questa operazione.
Il giorno successivo ho raccontato della distruzione del Jawazat ad un amico stretto che vive a pochi isolati da me. È un giovane gazawi, con l’intelligenza di un ragazzo di strada, esperto riguardo alle dinamiche della comunità. Abbiamo cominciato a discutere della nostra vicinanza a probabili bersagli: lui ha detto che stava semplicemente aspettando che attaccassero la stazione di polizia di Abbas (un obiettivo simbolico, colpito anche durante l’Operazione Piombo Fuso), un edificio che sta nell’isolato di fronte a quello dove lui vive con la sua famiglia. Verso le 2 del mattino seguente, la stazione di polizia è stata distrutta. L’esplosione è stata così dura che ha dilaniato una porta molto pesante a casa nostra, mandato in frantumi diverse finestre, e gettato nel panico la nostra famiglia. Ho cercato subito di allontanare i bambini dalle finestre, e sono corso a chiamare il mio vicino. Ha risposto e in meno di cinque secondi si è lasciato sfuggire che nonostante lui e la sua famiglia, grazie al cielo, non erano feriti, tutto il resto a casa loro era distrutto, e il loro edificio era seriamente danneggiato.
A casa nostra siamo diventati degli esperti in materia militare, specializzandi nel suono delle armi israeliane e palestinesi. Riusciamo a distinguere con facilità il suono degli Apache, i missili degli F-16, i droni, e i razzi Fajr usati da Hamas. Quando le navi israeliane bombardano la costa, si sente un tonfo caratteristico e ripetitivo, segnato dal ritardo di un secondo fra il lancio e l’impatto. Gli F-16 scendono in picchiata come se stessero lacerando il cielo, agganciano il bersaglio e distruggono interi isolati con una precisione devastante. I droni: a Gaza vengono chiamati zananas, alludendo al ronzio di un’ape. Sono creature inarrestabili, irritanti. Non sempre sono un presagio di distruzione; piuttosto, rimangono onnipresenti, controllano come fanno le guardie carcerarie. I razzi Fajr sono assolutamente terrificanti perché hanno il suono di razzi che arrivano in picchiata. Si sentono di rado a Gaza City, perciò li confondiamo spesso con degli F-16 che volano basso. Tutto ciò crea un paesaggio sonoro terrificante, e di notte ci stendiamo sui letti sperando che le bombe non cadano sulle nostre case, che il vetro non vada in pezzi sopra il letto dei nostri figli. A volte ci spostiamo di stanza in stanza nel tentativo di sentire un senso di sicurezza. La realtà è che non c’è scampo, né in casa né dai confini di Gaza.
È la mia prima harb (guerra), e ha smosso dentro di me dei sentimenti che ho tentato di sopprimere a lungo. Non ho mai voluto guardare ad Israele come ad una forza del male. Mi sono detto che questo tipo di pensiero, questo genere di emozioni, non sarebbero stati d’aiuto, non sarebbero stati costruttivi, che non sarebbero stati “da me”. Ho voluto lavorare con gli israeliani; per riconciliare, suppongo. Dopo quattro anni di vita a Gaza, per me questa è diventata una posizione insostenibile. Avrei avuto meno problemi con gli sforzi di Israele per proteggere i suoi centri abitati, anche attraverso attacchi mirati verso coloro che considera i suoi nemici, se avesse anche lavorato in modo convincente per la pace, verso il riconoscimento dell’umanità di quelli che soffrono per le conseguenze del suo assedio continuo. Per quanto ne so, Hamas sta ponendo come condizione per un cessate il fuoco la promessa che il blocco di Gaza verrà rimosso. Perché questa dovrebbe essere considerata una richiesta irragionevole? Se Israele potesse agevolare l’esportazione di beni da Gaza, costruire una fabbrica, o aiutare concretamente con la consegna puntuale dei materiali per la ricostruzione, gli effetti di trasformazione sull’economia e la vita sociale di Gaza non sarebbero da sottovalutare. La riduzione del tasso di disoccupazione, che ora è al 30 per cento, l’inversione della traiettoria devastante che l’ONU prevede per Gaza, è ciò che Israele – con l’appoggio dell’ONU, degli USA, dell’Unione Europea e di Tony Blair – potrebbe realizzare, e realizzare subito. Invece quello a cui ho assistito è un tentativo sistematico da parte del governo israeliano di privare i palestinesi a Gaza delle libertà essenziali e di far sì che non possano condurre una vita dignitosa; forse l’odio che si agita fra i palestinesi, allora, non è una conseguenza fortuita. Tutto questo è stato fatto nel nome dell’autodifesa, eppure niente di tutto ciò ha reso Israele chiaramente più sicura (nonostante i pugni sbattuti sul petto quando si parla dell’efficiacia dell’Iron Dome); la porta rimane aperta, dunque, alla necessità di operazioni come Pilastro di Difesa.
Soltanto la settimana scorsa scrivevo le parole “sii prudente” ad alcuni amici a New York. Mi ha scaldato il cuore vedere la mia bacheca di Facebook accendersi di messaggi di supporto e solidarietà per i newyorchesi angosciati; è stato un momento che ha forato la superficialità e l’auto-promozione che normalmente associo a questo mezzo di comunicazione. Quando sono iniziati i bombardamenti su Gaza ho iniziato a ricevere dei messaggi che mi dicevano di “essere prudente”. Le parole “sii prudente” indirizzate a dei palestinesi assumono un significato diverso; richiedono ai mittenti di prendere una posizione che potrebbe costare degli amici nelle loro cerchie. (In questo caso stare zitti potrebbe essere la meno costosa delle posizioni, e forse anche la meno equivoca.) Ad ogni modo, da allora anche questo supporto verbale è venuto meno. Il risultato è un silenzio assordante da parte di amici che, a quanto pare, si sentono incapaci di inviare messaggi di supporto.
Nell’assenza di una pressione reale dal presidente Obama e dai leaders degli altri stati occidentali per tenere a freno Israele, diventa ancora più importante che la maggioranza silenziosa parli apertamente. È il motivo per cui credo che dobbiamo lavoraro più duro per far capire a chi è ancora incerto chi è l’oppresso, e chi è l’oppressore. A volte rimaniamo intrappolati nei nostri social networks, dando per scontato che un articolo condiviso fra noi abbia la stessa presa altrove. La verità è che la maggioranza non sa, e in fin dei conti non gli importa niente. Molti fra loro si chiedono ancora se supportare la Palestina non equivalga ad appoggiare il terrorismo. Spero che in futuro fra i miei amici occidentali ce ne siano di più a sentirsi sicuri del fatto che confortarmi con le parole “sii prudente” non è così controverso come potrebbero pensare, e che significa di più questo, ora, per i palestinesi di Gaza, di qualunque altra cosa possano dire i loro leaders.
Wasseem El Sarraj
***
Wasseem El Sarraj è un ricercatore, scrittore e attivista palestinese nato nel Regno Unito. Vive a Gaza, e lavora presso Tida Gaza, un centro di ricerca e tutela legale con base nella striscia. Questo articolo è apparso il 19 novembre, due giorni prima dell’accordo di cessate il fuoco, sulla rivista statunitense The New Yorker.