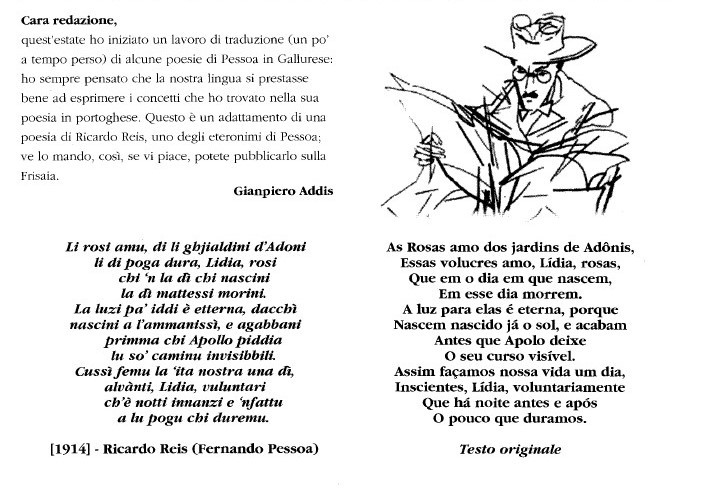La storia marginale della letteratura registra come curiosità il modo in cui fu composto e scritto il Kubla Khan di Coleridge.
Questo quasi-poema è uno dei più straordinari della letteratura inglese – la più grande, a parte la greca, di tutte le letterature. E la straordinarietà dell’intreccio coesiste e si fonde con la straordinarietà della sua origine.
E’ stato composto, racconta Coleridge, in sogno. Egli soggiornava di tanto in tanto in una tenuta solitaria, fra il villaggio di Porlock e quello di Linton. Un giorno, per effetto di un sedativo che aveva preso, si addormentò; dormì tre ore, durante le quali, dice, compose l’opera, poiché le immagini e le espressioni verbali che corrispondevano loro si originavano nella sua mente parallelamente e senza sforzo.
Una volta sveglio, pensò di scrivere quello che aveva composto; aveva già scritto una trentina di versi, quando gli venne annunciata la visita di un “uomo di Porlock”. Coleridge si sentì obbligato a riceverlo. Passò con lui quasi un’ora. Ma al momento di rimettersi a trascrivere quello che aveva composto in sogno, si accorse di essersi dimenticato il resto; si ricordava solo il finale del testo – altri ventiquattro versi.
E’ così che ci è giunto il Kubla Khan come frammento o frammenti, il principio e la fine di qualcosa di pauroso, di un altro mondo, raffigurato in termini di mistero che l’immaginazione umana non può concepire, e di cui ignoriamo, con un brivido, quale sarebbe potuta essere la trama. Edgar Poe (discepolo, che lo sapesse o meno, di Coleridge) non ha mai raggiunto, in versi o in prosa, l’Altro Mondo in modo così spontaneo o con la stessa sinistra pienezza. In Poe, pur con tutta la sua freddezza, rimane qualcosa di nostro, sebbene in forma negativa; nel Kubla Khan tutto è altro, tutto è Aldilà; e ciò che non si riesce a decifrare accade in un Oriente impossibile, ma che il poeta ha visto davvero.
Non si sa – Coleridge non ce lo ha detto – chi fosse quell’Uomo di Porlock che tanti, come me, avranno maledetto. Sarà stato per una coincidenza fortuita che è spuntato questo seccatore sconosciuto a disturbare una comunicazione fra l’abisso e la vita? Sarà sorta, tale apparente coincidenza, da qualche occulta presenza reale, di quelle che sembrano impedire di proposito la rivelazione dei Misteri, anche se intuitiva e lecita, o la trascrizione dei sogni, se in essi sia latente qualche forma di questa rivelazione?
Comunque sia, credo che il caso di Coleridge rappresenti – in forma esasperata, destinata a dar vita a una allegoria vissuta – ciò che capita a tutti noi quando in questo mondo tentiamo, con la sensibilità per cui si fa arte, di comunicare, falsi pontefici, con l’Altro Mondo di noi stessi.
Il fatto è che tutti noi quando componiamo, anche se siamo svegli, è come se lo facessimo in sogno. E a tutti noi, anche se nessuno viene a trovarci, si presenta dal nostro intimo “l’Uomo di Porlock”, il seccatore inatteso. Tutto quanto veramente pensiamo o sentiamo, tutto quanto veramente siamo subisce (quando lo esprimiamo anche solo a noi stessi) l’interruzione fatale di quel visitatore che siamo noi, di quella personalità estranea che ciascuno di noi ha in sé, più reale, nella vita, di noi stessi: la somma vivente di ciò che impariamo, di ciò che pensiamo di essere e di ciò che desideriamo essere.
Questo visitatore – perennemente sconosciuto perché, pur essendo noi, “non è nessuno” -, questo seccatore – perennemente anonimo perché, pur essendo vivo, è “impersonale” – tutti noi lo dobbiamo ricevere, per debolezza nostra, fra l’inizio e la fine di una poesia concepita per intero, che non permettiamo a noi stessi di vedere scritta. E quello che di tutti noi, artisti grandi o piccoli, sopravvive realmente, sono frammenti di ciò che non sappiamo cosa sia, ma che sarebbe, se ci fosse stato, l’espressione stessa della nostra anima.
Fossimo capaci di essere fanciulli, per non avere visite, né visitatori che ci sentiamo obbligati a ricevere! Ma non vogliamo far aspettare chi non esiste, non vogliamo offendere l'”estraneo” che è noi. E così, di quello che sarebbe potuto essere, resta solo ciò che è; della poesia, o delle opera omnia, solo il principio e la fine di qualcosa andato perduto – disiecta membra che, come disse Carlyle, sono ciò che resta di ogni poeta, o di ogni uomo.
***
[Fernando Pessoa, Obras em Prosa, cura, introduzione e note di Cleonice Berardinelli, Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1974, III, 398-400. Traduzione in Pagine Esoteriche, a cura di Silvano Peloso, Adelphi, Milano, 1997.]