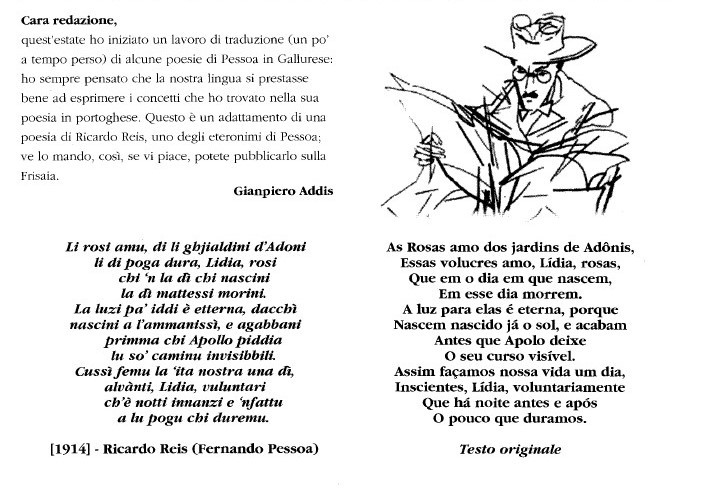Un classico riscoperto.
Vita di Antonio Gramsci non lo troverete certo in libreria nello scaffale delle novità: la prima edizione (Laterza) risale al 1966. Nel frattempo gli studi su Gramsci sono andati avanti, sono state pubblicate nuove edizioni critiche dei suoi Quaderni ed è stata pubblicata molta della sua corrispondenza in varie raccolte. Sulla sua figura è stato scritto di tutto: negli ultimi anni, poi, è rientrato di prepotenza nel linguaggio della politica e nello scenario mediatico, e le sue parole vengono ora utilizzate, spesso indiscriminatamente, da più parti e in molteplici occasioni – talvolta senza contesto, e piegate al fine di avallare la tesi di turno. Proprio per questo (ri)leggere oggi questo libro è estremamente salutare, perché aiuta a ricomporre questa centrifuga di pensieri entro i limiti di quella che fu la straordinaria coerenza e integrità del pensatore sardo. Fiori non perde mai di vista i punti fermi del suo pensiero: rifiuto del settarismo, scarsa disponibilità a “carcerarsi dentro formule magiche immutabili in qualsiasi momento storico”, importanza della filologia e rigore metodologico. È singolare che molti fra i suoi scritti vengano utilizzati oggi, invece, proprio come delle pillole cristallizzate, dei passepartout applicabili a qualsiasi momento storico, citazioni autorevoli ma impiegate in modo a-critico e che proprio per questo infrangono uno dei principi elementari del suo pensiero.[1]
Il grande merito della prosa di Fiori è quello di saper fornire in modo agile un quadro dettagliato e ben strutturato di questo incontenibile universo del sapere e del contesto storico di riferimento, anche quando si tratta di dover ricomporre momenti in cui l’attività politica di Gramsci si era fatta densissima, e gli avvenimenti precipitavano senza controllo. Fiori conserva in ogni pagina quell’incedere travolgente caratteristico della sua scrittura (leggete il suo magnifico romanzo Sonetàula) e articola il resoconto di una vita tanto gravosa con grande leggerezza, riuscendo del tutto nell’intento di dare “di Gramsci un ritratto a figura intera, con i tuffi del sangue e della carne”. Un libro che si chiude con una lacrima.
(Giuseppe Fiori, Vita di Antonio Gramsci, 2003, Nuoro, Ilisso.)
Un libro per l’indipendenza.

I quattro mori sono sempre stati, a memoria d’uomo, il simbolo riconoscibile della comunità sarda; una bandiera sventolata in migliaia di occasioni diverse, dai concerti del primo maggio a Roma fino alle recenti rivolte del movimento dei pastori, passando per l’etichetta della birra Ichnusa. Emblema della fierezza nazionale, veicolo per la rivendicazione di un’appartenenza specifica. Risalire il fiume dell’orgoglio col quale questo simbolo viene spesso ostentato, però, rivela ad uno studio attento alcune sorprese straordinarie, e richiede lo sforzo di accantonare ogni preconcetto prima di proseguire per la via che porta, attraverso una narrazione ricchissima di fonti, alla scoperta dei molteplici e contraddittori significati della bandiera sarda.
I quattro mori fanno la loro prima apparizione nel 1281, impressi su un sigillo del re Pietro III di Aragona il Grande, ma dovrà passare ancora molto tempo prima che la bandiera diventi il simbolo dell’isola e dei suoi abitanti nell’immaginario collettivo. In mezzo c’è Mariano IV, divenuto giudice di Arborea nel 1347, e la storia sommersa di come unì il popolo sardo sotto una sola bandiera, quella dell’albero deradicato verde in campo bianco, lottando contro i catalano-aragonesi e confinandoli nelle roccaforti di Cagliari e Alghero. L’albero, che inizialmente simboleggiava il giudicato insieme ai pali catalani, si fece largo rapidamente fino ad eliminare del tutto l’elemento iberico, e diventò così il primo vessillo di origine autoctona con cui i sardi arrivarono ad un soffio dall’indipendenza. Ma la sconfitta dei sardi giudicali e la vittoria dei catalano-aragonesi del 1409, nella piana di Sanluri, seppellì gli avvenimenti sotto un cumulo di macerie, depositate con cura anche dalla classe intellettuale sarda che nei secoli a venire lavorerà soprattutto per compiacere la classe dominante di turno, condannando così la storia nazionale a cadere nell’oblio, in cambio di precari riconoscimenti e di un’integrazione sospirata a lungo, e mai ottenuta completamente. Lo stesso triste destino toccherà all’altra rivoluzione mancata, quella anti-piemontese guidata da Giovanni Maria Angioy verso la fine del ‘700, prontamente rimossa dalla memoria collettiva e rispolverata solo quando gli animi si erano raffreddati abbastanza da poterla ammirare comodamente in un museo.
La bandiera dei quattro mori porta dunque con sé una carica simbolica zeppa di contraddizioni: da simbolo del popolo invasore, passerà a rappresentare l’orgoglio e il militarismo dei sardi, un impulso che dal XVI secolo si trascinerà fino all’età moderna per dare vita a quel sardismo che prende le mosse dal sentimento di fierezza e abnegazione dei reduci della Brigata Sassari. Fierezza per le proprie origini sarde e ardore patriottico italiano, ovvero orgoglio e integrazione. Una confusione semantica che porta oggi la regione Sardegna ad aver adottato i quattro mori come proprio simbolo ufficiale, dichiarando per iscritto che la loro origine resta ancora avvolta nell’incertezza, ma che il simbolo, certamente, da molti secoli identifica la Sardegna e il suo popolo nella sua unità e nella sua volontà di essere libero.
(Franciscu Sedda, La vera storia della bandiera dei sardi, 2007, Cagliari, Condaghes.)
- [1]Vedi anche Antonio Pigliaru, L’eredità di Gramsci e la cultura sarda, 2008, Nuoro, Il Maestrale.↩